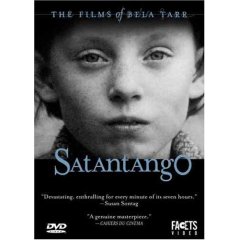Sátántangó
Regia: Béla Tarr. Sceneggiatura: Béla Tarr e Lázló Krasznahorkai, dal romanzo « Sátántangó » di Lázló Krasznahorkai. Fotografia: Gábor Medvigy. Musica: Mihály Vìg. Montaggio: Ágnes Hraiitzky. Costumi: Gyula Paver, Janos Breckl. Suono: György Kovács. Interpreti: Mihály Vìg (Irimias), Dr. Putyi Horváth (Petrina), Erika Bók (Estike), Peter Berling (il dottore), Miklós B. Székely (Futaki), Erszébet Gaál, Lázló Lugossy Jr. (signor Schmidt), Eva Almási Albert (signora Schmidt), Iren Szajki, Alfréd Járai, Peter Berling, Barna Mihok, János Derzsi. Produzione: MIT (Budapest), Von Vietinghoff Filmproduktion (Berlino), Vega Film (Zurigo), Magyar, TV Svizzera Romanda. Origine: Ungheria, Germania, Austria 1991-94. Durata: 450'. Formato: 35mm, bianco e nero, 1:1,66.
Nel suo «Stanze. La parola e il fantasma nella cultura occidentale», Giorgio Agamben ci ricorda come Heidegger abbia ripreso, nella sua analisi della banalità quotidiana, una terminologia che ci riporta dritti dritti all'elenco delle filiae acediae stabilito dalla letteratura patristica: categorie come "torpore" (che paralizza ogni ricerca della salvezza personale), "divertimento" (disponibilità allo svago come fuga «dalle possibilità più autentiche dell'esserci»), ma soprattutto "disperazione" («oscura e presuntuosa certezza di essere già condannati in anticipo e il compiaciuto sprofondamento nella propria rovina»), si riflettono, di volta in volta singolarmente o di concerto, nei film di Béla Tarr, da Nido familiare a Sátántangó, come veri e propri strumenti di visione, attrezzatura concettuale con cui mettere a fuoco coerentemente un'immagine del mondo e dell'umanità. Che cosa poi sia l' acedia, da non confondere con il significato banale conferito al contemporaneo "accidia" come "pigrizia", ce lo ricorda sempre Agamben: una «fuga dell'uomo davanti alla ricchezza delle proprie possibilità spirituali» (un ritrarsi dell'Uomo davanti all'impegno implicato nello stare in presenza di Dio, avrebbero detto i padri della Chiesa). La disperazione che ne deriva (la più importante e terribile delle filiae acediae) non riguarda tanto l'esistenza di quella ricchezza, e dunque del desiderio di conseguirla, quanto quella di una via che permetta di raggiungerla: bene, il cinema di Béla Tarr si muove proprio dalla convinzione che le condizioni materiali del mondo in cui viviamo, identificate nel prevalere definitivo della banalità, "soffocano" ogni ricerca di questa via e quindi il conseguimento della salvezza.
Procedendo per così dire a ritroso dal riconoscimento delle condizioni storiche che determinano il modo dell'esserci, messe in scena nei primi film, con Almanacco d'autunno, Tarr (si) detta i modi di un'evoluzione decisiva nella loro rappresentazione. Questo film, conchiuso nella claustrofobica scenografia di un appartamento che diventa metafora del mondo medesimo, si propone come sosta di riflessione e di messa a punto di un sistema di segni più adeguato alla irrevocabilità delle conclusioni raggiunte dal discorso fino lì elaborato. Dopo di che ci sarà l'incontro decisivo con lo scrittore Lázló Krasznahorkai, determinante per la stesura della sceneggiatura di Perdizione e del successivo Sátántangó, trasposizione di un suo romanzo pubblicato nel 1985. L'intenzione ontologica che si celava dietro le apparenze dell'approccio storico-sociale può, infine, venire alla luce; per ammissione dello stesso Béla Tarr, occorre riconoscere che il contributo di Kraznahorkai a questo sviluppo è stato determinante. Il cinema di Tarr si apre improvvisamente all'irruzione dello spazio e del tempo, disponendosi a lavorare principalmente sulle possibilità formali/concettuali che da questi provengono. L'aspetto narrativo, che già in Almanacco d'autunno mostrava la tendenza ad assottigliarsi, si rarefà ulteriormente; la scelta dell'ambientazione en plein air, in realtà trasforma il paesaggio magiaro in una sorta di metafora del mondo ancora di più, di un universo interiore nel cui invisibile labirinto l'individuo, ormai privato di ogni prospettiva, non potrà che aggirarsi all'infinito. La Natura, in particolare attraverso i due elementi acqua/terra, si afferma come un nemico insidioso: l'acqua che scende fitta e insistente dal cielo non purifica, anzi, mischiandosi alla terra produce fango, che invade ogni spazio di collegamento fra gli edifici, ogni via di collegamento e rende cosi concretamente visibile il torpore spirituale di uomini e donne che faticosamente vi si muovono. Una piccola digressione: quando Dante Alighieri, nel Canto VII dell'Inferno fa comparire in scena gli accidiosi (coloro che peccarono di acedia), ce li mostra impantanati nel limo, condannati per l'eternità a una collosa quasi-immobilità fisica e, insieme, verbale (la spiegazione che porgono della loro pena, la «gorgoglian nella strozza / ché dir nol posson con parola integra»).
Spazio e tempo, si diceva. Sia in Perdizione che in Sátántangó la dilatazione del tempo nei piani sequenza costruiti sovente su lunghe carrellate aumenta a dismisura l'esposizione del mondo allo sguardo, creando un luogo di appercezione a disposizione dello spettatore, uno "spazio intermedio" tra le cose mostrate nella loro corruzione, in cui chi guarda va ad installarsi sostenuto soltanto dalla sua sensibilità e dalla sua disponibilità. In questo modo, come sottolineava Angelo Signorelli, a proposito di Perdizione, in «Cineforum» n. 288. si crea «una fortissima tensione tra quanto viene rappresentato e l'espressione che ne lavora la presenza»; da questo punto di vista, Sátántangó procede nella medesima direzione con esiti ancor più memorabili. L'indagine "ontologica" che viene sviluppata sulla condizione umana, caratterizzata da una stasi spirituale mortifera, si traduce impercettibilmente ma, alla fine, con grande evidenza, in un'indagine "ontologica" sul cinema stesso, sulla dialettica che lo fonda, tra registrazione di oggetti (persone, cose, animali) e la loro nuova definizione come segni del testo che li accoglie. Quand'anche in quegli oggetti venga ricercata la testimonianza della sconfitta irrimediabile, è nell'atto stesso di ricomporli nella forma della rappresentazione, e in quello conseguente della contemplazione di quest'ultima, che "chi fa il film" e "chi lo contempla" si alleano e trovano nell'esperienza/visione delle forme senza tempo dell'acedia quell'«oscura saggezza secondo cui solo per chi non ha più speranza è stata data la speranza, e solo per chi in ogni caso non potrà raggiungerle sono state date delle mete») (G. Agamben, «Stanze», p. 13-14). (Adriano Piccardi, «Cineforum» 393)
L'ora dei falsi profeti. L'apocalittico film di Béla Tarr Sátántangó. L'estetica del film come fenomenologia del tempo e della realtà.
La storia di questo film, che malgrado il lento procedere ha dovuto essere compressa e ridotta alla sua struttura narrativa essenziale, non viene raccontata in maniera lineare e da un'unica angolazione, ma attraverso percorsi differenti e dalla prospettiva di un personaggio diverso (oppure gruppo di personaggi) o, per cosi dire, come nel caso delle scene nell'osteria, dal punto di vista del luogo dell'azione. Le singole storie, che si sviluppano parallelamente, ma che disposte in successione non si intrecciano l'una con l'altra, si sovrappongono variamente a tal punto che (con spostamento temporale) un medesimo avvenimento viene mostrato da diverse prospettive percettive. La struttura del racconto conferisce cosi una dimensione a quanto accade e al tempo. Volendo considerare l'aspetto metaforico e allegorico di questa storia, la modalità narrativa e la seducente, sobria, precisa e allo stesso tempo suggestiva tecnica di ripresa di Gábor Medvigy, seguono principalmente la traccia del cinema realista, anche se qua e là compaiono momenti prettamente stilizzati (per esempio, forti contrasti, in cui immagini in bianco e nero si trasformano in silhouette, la ripresa della telecamera dal basso) e scene oniriche, surreali (per esempio il movimento dei ragni sugli ubriaconi addormentati). Ciò che al film di Tarr Sátántangó conferisce la sua inconfondibile aurea e la sua eccezionale forza è il suo rapporto con il tempo. Da questo punto di vista (ma non solo) gli è molto prossimo il regista greco Theo Angelopoulos che però, per quanto riguarda la durata dei film, malgrado le sue pellicole più lunge di tre ore e mezza 0 Thiàsos (La recita) e 0 Megalexandros (Alessandro il Grande) già mettano a dura prova la resistenza degli spettatori, rimane di molto dietro a Tarr. Nella coincidenza tra tempo del racconto e tempo raccontato, che si protrae per lunghi momenti, Sátántangó si ricollega alla tradizione del film d'avanguardia e a nomi come Andy Wahrol o Michael Snow. Dal loro purismo e dal loro modo di soffermarsi, spesso per molte ore, in un unico spazio o addirittura in una posizione, il film di Tarr si differenzia per il particolare alternarsi di continuità e discontinuità: l'occhio della telecamera si ferma spesso, apparentemente senza far distinzione, su uomini in movimento e su uomini fermi, su spazi animati e su spazi vuoti. In riprese statiche della durata di diversi minuti nelle quali sembra che le immagini si trasformino ripetutamente in statue di ghiaccio e in lentissimi movimenti della telecamera in spazi e luoghi privi di azione, il tempo diviene oggetto di meditazione. Il tempo viene formalmente sospeso e la sua quantificazione, di tanto in tanto annunciata dal ticchettio solitario dell'orologio a muro, appare quindi del tutto inutile se non addirittura ridicola. Poi all'improvviso, salti temporali, cambi di scena e di prospettiva rinnovano la dinamica. In questo modo Sátántangó si trasforma pian piano in una fenomenologia estetica del tempo e della realtà. L'esecuzione artistica e cinematografica di Tarr stimola una riflessione sul valore ontologico dell'immagine filmica, il regista si chiede fino a che punto la telecamera permetta di cogliere la verità della realtà esterna e quale sia la sua possibilità di vedere oltre la superficie del visibile. Nessun film prima d'ora ha mai raggiunto in intensità la qualità che il grande critico e teorico cinematografico di ispirazione cristiana André Bazin (1918 1958) ha attribuito alla telecamera: quella forza primitiva che manifesta, che rivela in modo vero e puro le profonde dimensioni dell'essere.
Durante la discussione al termine della proiezione del film al cinema Arsenal di Berlino, Béla Tarr ha posto particolarmente l'accento su quale grande significato la forma abbia in Sátántangó proprio in base a ciò, tra l'altro, aspira ad essere inteso come un nuovo capitolo nella storia dell'estetica del film , affermando che «l'essenza di questo film» è costituita dal tentativo «di portare all'interno del linguaggio cinematografico un altro modo di osservare il mondo». Nella medesima occasione Lázló Krasznahorkai ha sottolineato ciò a cui abbiamo gia fatto riferimento sopra e cioè che «quello che c'è di interessante e di nuovo nel film è il rapporto con il tempo»; il film, continua Krasznahorkai, cerca soprattutto di esprimere l'idea che «non vi sono differenze di valore tra gli esseri animati, per cui risulta difficile tracciare distinzioni temporali. Il tempo non può essere soppesato». Assegnando ad ogni cosa il suo tempo, sulle orme della famosa frase da «Qoelet» (Ecclesiaste 3, 1-8) «Per tutto c'e un momento», e tollerando nel suo svolgersi durata, monotonia e ripetizione ben oltre il limite di sopportazione, il film non solo definisce il tempo in maniera nuova, ma riesce persino a trascinare lo spettatore nella sua dimensione così che, all'apparenza terribilmente lento e senza fine, dà in conclusione l'impressione di essere più corto di certe malriuscite pellicole d'azione.
Tanatografia dell'Est
Il film apre nuovi spazi al sentire e al riflettere, così come il romanzo omonimo a cui Tarr e Krasznahorkai si ispirano. Tuttavia "II tango di Satana" non è il primo esempio che dimostra come il mezzo cinematografico nell'evocazione dell'atmosfera principale e portante dell'opera possa essere superiore alla parola scritta. Proprio nella centralità semantica di spazio e tempo il film raggiunge meglio del romanzo una grande forza espressiva.
Sátántangó appare come una descrizione visionaria della decadenza economica e morale del socialismo reale in Ungheria. Rappresenta una fenomenologia del disastro, un'esplorazione delle condizioni interne ed esterne di tale disastro e delle sue conseguenze, un'indagine delle cause che in un tale disastro si possono rintracciare.
Nel suo film Tarr pone l'accento sul tema della stagnazione, dell'inutile attesa; i personaggi, metaforicamente scoloriti dalla pioggia insistente, perdono ogni traccia di volontà, precipitando in abissi di grigiore e depressione, dove crescono striscianti disprezzo, degrado e violenza.
-Oscuramento della fede?
Il film pone domande su che cosa sia il bene e il male, sull'essenza del peccato individuale e collettivo e indirettamente sul significato della punizione e del perdono. Si chiede inoltre quale sia il valore e l'importanza della Chiesa in un mondo così degradato: diventato ormai bigotto e settario, nemmeno il Cristianesimo ha più risposte valide da dare. In generale il film appare come una metafora apocalittica della decadenza dell'umanità. Tutto è pervaso dall'alone pessimistico della filosofia dell'assurdo, l'occhio di Tarr mostra solo rassegnazione, vuoto e cattiveria, la bontà e l'amore non esistono più.
-La storia della redenzione al contrario
Malgrado il film non riprenda le scene di carattere prettamente religioso descritte nel libro, non manca di richiamarsi in diversi punti ad iniziare dal titolo alla storia della redenzione, nonché a motivi biblici e cristiani in generale. Fondamentale nella metafisica teologica del film il parallelismo tra il personaggio Irimiás (Geremia) e il Geremia biblico, entrambi guide del proprio popolo, ma nel caso del profeta verso la salvezza, nell'annientamento e nella perdizione per Irimiás . Sorprendenti, inoltre, le affinità, anche se in prospettiva ribaltata, tra Gesù Cristo e Irimiás , il falso messia. Lo scenario di decadenza descritto da Tarr e Krasznahorkai si presta ad essere letto come una contro-interpretazione della storia della redenzione: dopo l'arrivo del falso Cristo la storia non procede in avanti, ma retrocede sempre più fino ad arrivare all'inizio della creazione; alla fine del film il dottore chiude gli occhi sul "guazzabuglio cosmico" come egli ha definito il mondo nel suo diario evidentemente sulle orme del «Tohuwabohu» [ebr. «massa senza forma e vuota» Gen. 1,2] della storia della creazione.
-Campane nel buio
II film di Tarr gira allo spettatore la domanda se la decadenza lasci ancora un barlume di speranza e se in essa ci possa essere qualche elemento di salvezza. Se lo spettatore, alla ricerca di una risposta, riflette sul messaggio del Geremia del vecchio testamento, troverà il conforto nel leggere che l'annientamento non è totale ma arriva solo al punto in cui sia possibile un nuovo inizio (cfr. 4,27; 5,10.18). II grande paradigma della decadenza e del nuovo inizio è la storia del diluvio universale (Gen. 6 e succ.): la pioggia insistente in Sátántangó non richiama forse alla memoria proprio questo racconto? E l'osteria in cui si cerca riparo non appare come un'arca in rovina? Per Geremia, che è consapevole della presenza del creatore nel creato, la pioggia è il simbolo che Dio si manifesta: «Alla sua voce le acque si ammassano in cielo» (10, 13). In Sátántangó la pioggia non spinge più gli uomini al pensiero di Dio. Per questo il Dio dimenticato si fa sentire ancor nelle campane, che lasciano intuire la sua presenza. Solo alcuni eletti sono in grado di sentirle, ma neppure loro sono (ancora?) capaci di dare un senso a queste esperienze che si incrociano e accavallano. Può farlo lo spettatore? Poco prima di sbarrare con chiodi e assi la sua finestra il dottore fa ancora una breve visita alla rovina della cappella, perché anche lui ora sente le campane, quelle che all'inizio del film avevano svegliato Futaki da un sonno forse più che semplicemente fisico. Nella rovina si trova solo un balordo vegliardo che batte una rotaia di ferro producendo un rumore assordante mentre continua a gridare: «Arrivano i turchi!» (un riferimento a Geremia: una minaccia di distruzione del tutto analoga a quella di Israele da parte degli Assiri e Babilonesi). Apparentemente calmatosi «Che idiota! Confondo il tonante scampanio celeste con le campane a morto!» il dottore torna indietro. Gli arcani rintocchi però continuano insistenti e hanno lentamente la meglio sul rumore tonante del ferro. Alla fine quando lo schermo, dopo aver mostrato pioggia per ore, sprofonda nel buio, lo scampanio celeste diviene sempre più forte. Lo scuro abisso si è aperto ma le campane chiamano ancora. (Reinhold Zwick, «Orientierung»58, 1994. Le parti in corsivo sono un riassunto a cura del traduttore)